La divina felicità pinta della nostra effige felice
Pubblicato in La dipinta Commedia, 2021
Nell’estate del 1320 Dante, oramai stabilitosi a Ravenna, forse raggiunto da tutta la famiglia, senza dubbio in compagnia dei due figli maschi, Jacopo e Pietro, è un uomo finalmente felice. Bastano le prime righe dell’epistola XIII a Can Grande della Scala per avere certezza di questo suo sentimento. Le ragioni di questa attesa felicità sono solo in parte familiari. Come, solo in parte, sono attribuibili all’esser riuscito a completare, tra scienza divina e fatti umani, la Commedia e, per l’assoluta grandezza di essa, essersi meritato più di ogni altro il “cappello” di poeta. La felicità di Dante non è solo quella dell’esule che ha ritrovato casa e famiglia, né è quella di chi è riuscito a far coincidere il proprio io ideale con il proprio io reale: le proprie ambizioni con le proprie realizzazioni. La sua è una felicità diversa, filosofica; una felicità prima. Nel significato di metafisica e, in questo senso, è una felicità divina.
Dunque in quell’estate che sarebbe stata l’ultima della sua vita, Dante compie un gesto di doppia generosità, proprio di chi vive in uno stato di felicità speciale. La generosità, si sa, è misura della felicità. A Can Grande della Scala dedica la cantica del Paradiso e, nel farlo, desidera chiarire il significato autentico della sua opera, svelando, come in uno schema Linati ante litteram, il senso profondo della Commedia. La storia filologica di questa epistola è nota: solo i primi 7 capitoli dei 33 canonici che la compongono, sono attribuibili a Dante, il quale ne avrebbe interrotto la stesura dopoché il “victorioso” Can Grande non era più tale a seguito della sconfitta subita alle porte di Padova il 25 agosto 1320. I rimanenti 26 capitoli sarebbero stati invece composti una decina d’anni dopo, probabilmente da un anonimo dotto teologo di Sant’Eufemia in Verona, con il fine di dare compimento e universale conoscenza a quanto l’epistola intendeva esprimere: la dedica della terza cantica a Can Grande in modo così da legare per sempre la città scaligera al sacro poema; e, cosa più importante, assolvere al desiderio di Dante di comporre un “accessus” che indirizzasse il lettore della Commedia all’alto intendimento di essa. L’operazione riesce solo in parte. Il dotto teologo centra il primo obiettivo: è universalmente nota la dedica del Paradiso a Can Grande, a lui offerto e affidato, “vobis ascribo, vobis offerto, vobis denique recommendo”, ma, viceversa, il dotto teologo fallisce nel comporre l’”accessus” all’opera, che risulta un insieme di precetti decisamente noti della retorica medioevale, ad eccezione di un punto su cui a breve torneremo, che potrebbe far pensare che Dante avesse, dopo la composizione dei primi 7 capitoli, lasciato nel manoscritto perduto, come tutti gli autografi del poeta, una serie di annotazioni sui capitoli da comporre.
Comunque sia, i primi 7 capitoli dell’epistola dicono già molto di come Dante desiderava che si leggesse la Commedia. Che non è affatto il modo di come la si è sempre letta, grandioso affresco storico e summa dottrinale del Medioevo. La Commedia, nell’intendimento del suo autore, è un viaggio, così nel capitolo 7, “anime de luctu et miseria peccati ad statum gratie”, che, capitolo 15, il dotto teologo riprende quasi letteralmente: “si può dire in breve che il fine di tutta l’opera e della parte consiste nell’allontanare quelli che vivono questa vita dallo stato di miseria e condurli a uno stato di felicità”. La Commedia, quindi, sarebbe il viaggio che conduce l’uomo alla conoscenza della felicità.
Ma come può l’uomo aspirare alla felicità? E di quale felicità si tratta? Quella degli affetti o del successo? Dante, come abbiamo detto, nell’estate del 1320 viveva l’una come l’altra. Ma non è a questa felicità che si riferisce, quando, componendo l’epistola per chiarire quale sia la lettura alta della Commedia, sceglie come primo complemento oggetto di essa, appunto, la parola “felicità”.
A te, Can Grande, così inizia, io, Dante, soggetto, “fiorentinus natione non moribus” auguro, che cosa?, “vitam felicem”. E per attuare tale augurio dedica e dona, così nel capitolo terzo, la cantica suprema della sua Commedia, avvertendo che, capitolo settimo, si tratta di un’opera dal significato “polisemos, hoc est plurim sensuum”.
Non aggiunge altro, ma il messaggio è chiaro. Tra incontri e dialoghi con personaggi della storia e del presente; tra fatti antichi e passati e vicende contemporanee; tra allegorie e simboli; tra dottrine filosofiche, cosmologiche, teologiche, esiste nella Commedia un “sensuum” altro, filosofico, “hoc est non gratia speculativi negotii, sed gratia operis”, cioè di saggezza pratica di vita, cioè ancora, “di aver coscienza del meglio che è in noi”, capitolo secondo, che, per Dante, è ciò che porta gli uomini alla “vitam felicem”. Così, dunque, all’uomo più potente del suo tempo, Dante augura una vita felice offrendo ciò che contiene il sapere per una vita felice. La Commedia è, nella sua essenza, “un’analitica dell’esistenza”. Pensiero poetante e poetare pensante della “grande conoscenza” quale comprensione originaria, e in ciò unitaria e totalizzante, della vita umana. Ogni canto della Commedia ha, in livelli di profondità di lettura dissimili, un pensiero del sapere originario dell’esistere dal cui apprendimento si giunge, come si diceva, alla felicità prima, propriamente alla felicità filosofica intesa come metafisica e quindi divina, nel senso, esattamente, espresso nel verso 131 del trentatreesimo canto del Paradiso, autentico, potentissimo, ideale explicit del Commedia, quando Dante e con lui il lettore-filosofo vedono il volto di Dio pinto dell’effige dell’uomo. Dell’uomo felice.
Un canto particolarmente rivelatorio di questo “sensuum” filosofico della Commedia è il canto primo del Purgatorio, in cui Dante si pone la domanda più grave: chi è l’uomo forte. L’uomo solido. Quello su cui si può contare sempre. L’uomo che sa sopportare le fatiche, i dolori, le pene della vita. Chi è l’uomo che propriamente si può chiamare “Uomo”: quello che Cicerone nel De Officis aveva chiamato, con un’espressione semplice al punto di poter sembrare disarmante in confronto di ciò a cui il suo significato rinvia, “vir bonus”?
Dante si pone la domanda più grave all’inizio del Purgatorio, perché, della risposta, è lui stesso ad averne bisogno. Ha appena concluso la scrittura dei 34 canti dell’Inferno. Ci ha impiegato almeno 8 anni, ma forse sono quasi il doppio, se fosse vero che ha iniziato la Commedia quando era ancora a Firenze. Davanti a lui ha altri 66 canti da scrivere. Il doppio, meno uno, di quelli che ha scritto. Con quei ritmi servono almeno altri 16 anni. Dante ne ha già compiuti 50. È vero che nel Convivio scrive che l’età perfetta per morire è 81 anni (la perfezione del numero 9 moltiplicato per se stesso), ma per un uomo del medioevo 50 anni è già un’età venerabile. Infatti lui ne vivrà solo altri 6. E in questo breve arco di tempo deve scrivere ancora tutto il Purgatorio e tutto il Paradiso. E, poi, ha anche il problema della lingua. Quella di cui si è servito nella prima cantica, in cui poteva utilizzare espressioni anche triviali, come “ed elli avea del cul fatto trombetta” o “che merda fa di quel che si trangugia”, non potrà più essere la lingua delle altre due cantiche, le quali, l’una, il Purgatorio, ha per ambientazione un’ideazione che risale a pochi decenni prima, 1200 circa, su cui quasi non esistono libri, ragion per cui Dante è costretto a inventarsi quasi tutto; l’altra, il Paradiso, è il regno della pura luce e dello spirito, inesprimibile a parole umane, come egli stesso riconosce all’inizio della terza cantica.
Di fronte a tutto ciò, Dante è in crisi. Teme di non farcela. Dopo l’euforia di aver rivisto le stelle all’uscita del budello infernale, cade in depressione. Si è perso d’animo, non crede più in se stesso. Aspira a un passaggio dalla felicità come momento dell’essere alla felicità come stato dell’essere. Perché la felicità di aver rivisto le stelle e di aver concluso la prima cantica è già svanita. In questo primo canto del Purgatorio, Virgilio ricorda e così attualizza lo stato di “follia” di Dante, che quasi lo aveva portato a vedere “l’ultima sera”. Cioè, addirittura, ad esser stato sul punto di procurarsi la morte.
Ma Dante reagisce, ponendosi la domanda più grave: chi è l’uomo che sa affrontare tutto ciò? E Dante si rasserena, trovando la risposta alla domanda più grave nell’incontro con Catone e nel dono che Catone gli fa.
Ma perché Dante sceglie Catone, che è un filosofo precristiano, e Dante pone chi è morto senza conoscere Cristo nel Limbo? Risposta: Catone è un filosofo stoico ed è simbolo più di qualsiasi altro di quella fermezza dello spirito, di cui Dante sta sentendo il bisogno. Daccapo, perché Dante pone proprio Catone sulla soglia del Purgatorio che è un suicida, quando colloca i violenti contro se stessi nel 7° cerchio dell’Inferno? Risposta: il suicidio di Catone è l’allegoria dell’uomo che sa uccidere il proprio vecchio io per far nascere un proprio io migliore, così come sono chiamate a fare le anime del Purgatorio, la cantica in cui si persegue il proprio miglioramento; così come era accaduto a Dante stesso capace di uccidere e, per due volte, la sua “follia”.
Accadde allora che Dante incontri Catone, il simbolo dell’uomo dalla ferrea moralità e dell’uomo che sa migliorarsi, il quale, inaspettatamente, dona a Dante un ramoscello di giunco, l’unica pianta che in virtù della sua flessibilità sopravvive ai venti violenti e alle mareggiate impetuose che sferzano la costa del Purgatorio. L’inflessibile offre la flessibilità. Non si tratta di una contraddizione, ma di un completamento. Heidegger direbbe che anche i tornanti delle strade di montagna invertono la nostra direzione per portarci alla sommità del passo e metterci nelle condizioni di superarlo.
Ecco allora la lezione di Dante: per essere un uomo propriamente tale si deve essere interiormente inflessibili, come Catone, ed esternamente, cioè verso tutto ciò che è altro da noi, come le mareggiate e i venti violenti, flessibili, condiscendenti, come il giunco. “Oh maraviglia…” dice Dante parlando del giungo e ritrovando se stesso: “cotal si rinacque/ subitamente là onde l’avelse”; oh meraviglia, questo ritornare se stessi subito e dove siamo stati abbattuti.
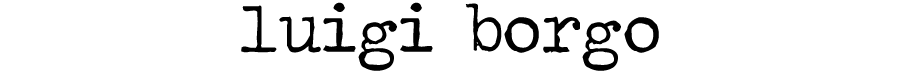




Leave a Reply