L’opera critica di Giuliano Menato
Pubblicato in “Far conoscere l’arte”, 2020
Circa trent’anni fa Giuliano Menato iniziava la stesura del suo saggio dedicato alle arti figurative del ‘900 per la “Storia di Vicenza” con una premessa, a pelle viva, sul collezionismo vicentino. Lo spunto era una “lacunosa”, “modesta” mostra tenuta vent’anni prima, esattamente nel 1971, presso il Museo Civico a Palazzo Chiericati che rappresentava ancora una ferita aperta nella millenaria storia cittadina. La mostra a cura di Passamani, Magagnato e Barioli aveva evidenziato un collezionismo vicentino di età contemporanea, 1900-1960, di “mediocre qualità”, espressione di un “panorama povero di vera sostanza artistica”, addirittura, per alcune opere, dalla “storia incerta”, dalla dubbia autenticità. Menato, dunque, iniziava la sua “ricapitolazione” delle personalità artistiche attive nel vicentino nei primi sei decenni del XX secolo, parlando di un collezionismo di croste e di falsi.
Non si trattava di polemica. Il contesto, l’elegante e pregevole edizione in sei tomi della “Storia di Vicenza” a cura di Franco Barbieri e Gabriele De Rosa per i tipi della Neri Pozza, il grande editore, quello del primo Montale, dell’esordio di Goffredo Parise, dei cinque tomi della “Storia della cultura veneta”, non lo permetteva. Era un fatto, questo della mediocrità del collezionismo vicentino, che, al pari di un’epidemia o di una guerra, la bimillenaria storia cittadina registrava, per voce di Menato, nel suo tomo dedicato all’arte contemporanea. Invero tutto questo secondo tomo del IV volume è una meraviglia di onestà intellettuale. Non credo esista nessuna storia “ufficiale” di città – all’epoca, primi anni ’90, erano uscite le storia di Milano, Verona, Mantova, Brescia – in cui, come nel citato volume, si sia arrivati a storicizzare così a chiare lettere i limiti culturali della società di cui si stanno raccontando gli atti memorabili. Vicenza terminava il racconto della propria illustre storia con la presa di coscienza della sua attuale mediocrità artistica. Unica eccezione, la letteratura, che si era salvata, a riprova di ciò, producendo libri di assoluto valore proprio attraverso il racconto e, in alcuni casi, anche la lingua di quella profonda provincia che fu la realtà sociale e culturale vicentina nei primi sei decenni del secolo scorso.
In altre parole, in quelle pagine sul collezionismo vicentino, su cui tuttavia ritorneremo per il carattere speciale della prosa espressa, Menato ha fatto, nel genere della critica d’arte, quello che hanno fatto gli scrittori vicentini raccontando, senza veli, Vicenza e la sua provincia: operazione meravigliosa, dicevamo, e in sé necessaria per uscire da quel grigiore periferico che ha segnato per così lungo tempo la nostra terra.
Menato tornerà nei decenni successivi a scrivere sul tema, perché se da un lato conoscere il collezionismo locale è funzionale alla sua aspirazione di onnisciente conoscitore dell’arte del territorio, dall’altro ciò risponde alla sua missione civica di promotore della grande arte ai suoi co-provinciali, la cui efficacia d’azione non può che misurarsi anche nell’incremento della passione per l’arte e il suo collezionismo.
Così vi ritorna spesso a parlarne. Lo fa in varie occasioni sulla stampa e, in particolare, in un saggio del 2011 di presentazione al volume dedicato a “Le mostre trissinesi”. Questa volta è il collezionismo della provincia della provincia, Trissino di Vicenza, a essere al centro delle sue osservazioni. Sono trascorsi quasi vent’anni dalla prima riflessione sul tema. Il panorama che ne esce ora è assai diverso. Se Vicenza non poteva vantare un collezionismo eccelso, il territorio aveva le sue eccellenze. A Valdagno c’era la collezione Marzotto, esposta in Basilica Palladiana nel 1994, l’anno successivo all’edizione della “Storia di Vicenza”. Si trattava, invero, di una raccolta di quadri dell’Ottocento, ma sia l’indiscutibile qualità delle opere in catalogo, sia i criteri di scelta e di acquisizione delle stesse erano espressione di un “fare collezionismo” di livello internazionale, che in qualche modo assurse a riferimento del genere. Inoltre, sempre a Valdagno, era stata esposta, nel 2001 nella curatela dello stesso Menato, la collezione comunale; a Montecchio Maggiore, quella di Alessandro Ghiotto; a Malo, quella sulla grafica internazionale di Giobatta Meneguzzo e poi a Trissino giovani imprenditori avevano da circa un decennio iniziato a costituire le loro raccolte. Una provincia della provincia che stava dimostrando un interesse per l’arte tutt’altro che mediocre, periferico ed estemporaneo, verso il quale Menato provava un sincero compiacimento.
Fa quindi un certo effetto, adesso, assistere alla presentazione pubblica della collezione privata di colui che è stato prima lo storico e poi il critico e anche il suggeritore di tanta parte del collezionismo vicentino. È nelle cose che la collezione Menato non sia attesa come una collezione qualsiasi. Ma che, anzi, essa rappresenti nelle opere selezionate la prova tangibile di una teoria critica lunga mezzo secolo. A Menato, tuttavia, il coraggio della sfida non è mai mancato e così, ecco, la sua quadreria. Innanzitutto i numeri: sono 62 artisti e 140 opere, di cui meno della metà (59) di genere figurativo mentre il restante (81) è ascrivibile al genere astratto. L’opera più antica è del 1925 di Francesco Noro, quella più recente è del 2018. Quasi un secolo, questo va rilevato, 93 anni per l’esattezza, di arco temporale. Tre, invece, sono le aree geografiche di provenienza degli artisti: veneta, lombardo-tosco-emiliana-ligure, romana-campana. Gli artisti veneti sono i più numerosi: 33 con una leggera supremazia di figurativi, 17, sugli astrattisti, 16; di poco meno, 20, gli artisti lombardi-tosco-emiliani-liguri con una maggioranza di genere inversa rispetto ai primi: più gli astrattisti, 15, sui figurativi, 5; infine 10 i romani-campani, di cui 6 sono gli artisti astratti e 4 i figurativi. Una collezione decisamente bilanciata tra le due macro-categorie della pittura del Novecento e ben distribuita nelle tre aeree di provenienza degli artisti. La sensazione è che si tratti di una raccolta fortemente unitaria: un secolo di pittura veneta-lombarda e dell’Italia centrale. Ma soprattutto è una collezione che ha una chiara specificità.
Diversa da quella di Ghiotto e di Meneguzzo, che sono collezioni propriamente tali, ovvero selezioni rigorose di opere di uno specifico ambito, e diversa anche da quella di Neri Pozza, la cui collezione non è altro che la raccolta dei quadri che lui e la moglie Lea Quaretti avevano acquistato per adornare le proprie case, quella di Menato appartiene a un altro genere di collezionismo, che è quello, per citare i casi più illustri, della collezione ai Tatti di Berenson o della collezione a villa Tasso di Longhi: è il collezionismo di uno storico e critico d’arte. È, o meglio, la storia per immagini di una vita dedicata allo studio dell’arte per la valorizzazione degli artisti e la divulgazione delle loro opere al grande pubblico. Ben 21 opere, infatti, presentano sul loro retro la dedica di gratitudine autografa dell’artista al critico. Ma essa è anche la storia dell’offerta artistico-culturale di un intero territorio. Di più, essa è, per chi ha seguito le centinaia di mostre curate da Giuliano Menato, la storia della propria educazione artistica.
Per 50 anni Giuliano Menato è stato, infatti, il principale motore della conoscenza dell’arte contemporanea nel vicentino. Pochi possono vantare un impegno come il suo: 25 anni a Trissino come curatore del Premio Nazionale di Pittura; 10 anni ad Alte Ceccato come direttore artistico della Galleria Modigliani; 25 anni a Valdagno al fianco dell’amministrazione cittadina nelle proposte della Galleria Civica; 6 anni a Recoaro Terme con esposizioni sulla grafica veneta contemporanea; 35 anni a Sarego per le rassegne agostane; 11 anni a Cittadella, in cui è stato il direttore artistico del Palazzo Pretorio; una presenza continua a Lonigo e a Vicenza, dove ha curato decine di mostre personali e collettive; infine dal 1986 a oggi nella sua Montecchio, prima nella sede della scuola elementare Manzoni e dal 2014 nella nuova sede dell’ex rimessa delle ferrotranvie vicentine di San Vitale: 33 anni di direzione artistica della locale Galleria Civica.
Un impegno straordinario, che era iniziato quasi per caso, nei corridoi dell’Istituto tecnico Marzotto di Valdagno, in cui un giovanissimo Vittorio Matino aveva proposto al collega, di poco maggiore, di presentarlo nella mostra che avrebbe tenuto a Vicenza presso la Galleria L’Incontro. Menato si era laureato in Lettere con indirizzo Storia dell’Arte, discutendo una tesi sul pittore barocco Louis Dorigny. A quei tempi l’Università di Padova non aveva ancora istituito la cattedra di Storia dell’Arte Contemporanea, per cui l’avvicinamento di Menato alla nuova arte avviene solo parzialmente all’interno dell’Ateneo. Il suo relatore di tesi, Rodolfo Pallucchini, tra i massimi esperti della pittura veneta del ‘500, ‘600, ‘700 e tra i fondatori del centro studi Andrea Palladio, ricopriva in quegli anni il ruolo di segretario generale della Biennale di Venezia e questo fece sì che Menato ne fosse un assiduo frequentatore, e poi il professor Sergio Bettini, a margine del suo corso di Storia dell’Arte Medioevale, era solito tenere alcune lezioni sulle Avanguardie del Novecento, che il giovane Menato frequentava con “seguace ingegno”. Altro, l’università non offriva. Fu quindi il contesto valdagnese a dargli gli stimoli maggiori. Era quello il tempo in cui un giovane residente a fondo valle, a metà strada ovvero tra Vicenza, a sud, e Valdagno, a nord, cercando stimoli culturali, ma in genere sociali, si poneva la domanda di dove sarebbe stato meglio per lui recarsi, se a sud o a nord della valle, e tante volte era proprio la proposta valdagnese a imporsi su quella del capoluogo. È qui, infatti, che Menato matura la sua formazione culturale post universitaria. A Valdagno, dal 1950 si tenevano le rassegne d’arte, che dal 1958 divennero internazionali, del Premio Marzotto. A Valdagno la nuova città, voluta e realizzata da Gaetano Marzotto, offriva il più grande teatro del Veneto, la cui facciata fu, per un certo periodo, opera di quel Giuseppe Santomaso, di cui Menato curerà, ancora vivente l’artista, un’importante antologica di grafica, e poi la Scuola di Pittura, la Fotoricerca, la Scuola di Musica, le scuole tout court di ogni genere e grado. C’è un aneddoto su questo tema e su questo periodo, scritto dallo stesso Menato: “Ma l’interesse per l’arte contemporanea mi crebbe dentro, facendomi fare un salto di qualità, a seguito di vivaci discussioni suscitate da un mio alunno liceale, che frequentava allora la Scuola di Pittura Marzotto diretta da Angiolo Montagna. Quel giovane [si tratta di Francesco Busato, poi insegnante di filosofia presso lo stesso liceo] altrettanto attento all’espressioni artistiche del passato, mi metteva al corrente dei suoi progressi nell’esercizio pittorico, mi parlava della sua predilezione per l’espressionismo astratto, mi intratteneva con discorsi che arrivavano ai principi stessi dell’arte moderna. Per evitare un complesso d’inferiorità mi impegnai ad approfondire per conto mio la conoscenza dei nuovi movimenti artistici, aggiornandomi alquanto rispetto ai programmi scolastici che dispensavano docenti e alunni dal possesso della materia oltre il Neoclassicismo di Canova. Acquistai perfino un quadro astratto da quel giovane allievo di Montagna: e fu il primo da me posseduto”.
Menato sarà sempre vicino alla Scuola di Pittura Marzotto e soprattutto al suo maestro, Angiolo Montagna, di cui diventerà il principale storico e critico. L’ambiente valdagnese, quindi, gli fa da stimolo. Scrive, a conclusione di un pezzo per la mostra tenuta a Villa Valle del 1984 dedicata alla Scuola: “si capisce, così, come Valdagno si distingua tra gli altri centri della provincia, in virtù proprio di un particolare interesse rivolto alle moderne arti figurative”.
Ma Valdagno è anche altro per il giovane professor Menato. È anche il luogo della sua maturazione politica. Era cresciuto nel segno degli ideali socialisti, che aveva ricevuto dal padre, ma è nell’ambiente valdagnese che trova gli stimoli per il suo impegno nel Partito Socialista, di cui per decenni sarà il consigliere di minoranza nel comune di Montecchio. Quello che trova a Valdagno è il socialismo di Sergio Perin, quello dei principi repubblicani, dei contenuti sociali, dell’istituzione delle Regioni, dell’Europa come federazione di Stati. Era il socialismo che originava dal Partito D’Azione, che aveva vissuto la Resistenza come continuazione ideale delle lotte risorgimentali per la pace e la libertà. Un socialismo che non fu mai massimalista ma moderato e riformista, fatto di argomenti, progetti, idee. Anche sogni. Ai giovani che lo frequentavano nell’impegno politico, Sergio Perin sapeva trasmettere “l’aspirazione e il gusto di costruire la storia”, come ha scritto Vittorio Sandri. Menato è tra questi giovani che ne acquisiscono il respiro, la visione, il pensiero, financo il carisma che consisteva in quel modo speciale di vivere la politica come vocazione autentica di offrire la propria intelligenza e cultura, il proprio tempo e impegno per il miglioramento della vita di tutti.
È proprio Sergio Perin a indicare Giuliano Menato come rappresentante per il Partito Socialista in seno al consiglio d’amministrazione della Fiera di Vicenza, di cui diventerà poi il più giovane vice-presidente.
Ma quello che il giovane Menato ha ricevuto dal territorio l’ha ampiamente restituito. In politica e in cultura: trent’anni dell’una, mezzo secolo e oltre dell’altra. Quando, infatti, i giovani più brillanti della sua generazione, da quelli una decina di anni più anziani, Parise, Piovene, Meneghello, Barolini, Ghiotto, Meneguzzo, Danese, a quelli di poco più giovani, Federico Faggin, Vittorio Matino, se ne andavano da Vicenza e dalla sua provincia, una “diaspora”, la definì Neri Pozza, “qui nessuno scampa” (Bandini), in fuga dalla mediocrità e dai limiti oggettivi di un’offerta culturale assai modesta, che non permetteva a un giovane di affermarsi completamente e di realizzare se stesso, Menato fu tra quelli che vi rimasero. Anzi, egli sale a nord la valle. È probabile che l’impegno politico, come dirà Bandini, rispondendo alla sua scelta di restare, sia stata la “tela del ragno”, che lo ha tenuto legato al territorio. La sfida, ovvero, di fare qui, tra la sua gente, nel paese in cui è nato, la sua parte per il rinnovamento del mondo. Zanzotto, che fu un altro che scelse la provincia, diceva che “nel paese natale non si muore mai… si nasce soltanto, si continua a nascere”.
L’impegno di Menato è stato certamente in questo senso: fare la sua parte fino in fondo per far nascere e crescere una coscienza artistica verso l’arte contemporanea nella sua terra. Egli è stato l’uomo delle istituzioni nella politica culturale del territorio.
Al centro della sua visione per una cultura pubblica c’è l’istituzione delle Gallerie Civiche, a cui riconosce il ruolo imprescindibile di potenza prima della vita culturale della città. Esse sono il luogo fisico, concreto in cui esercitare il pensiero, in cui avvicinarsi alla bellezza. La vita municipale nella sua dimensione più alta non può che realizzarsi tra quelle mura, in quei momenti d’arte e d’incontro. A Valdagno, l’attività della Galleria Civica ha proseguito, sotto la sua direzione, le rassegne d’arte che erano iniziate con i Premi Marzotto, migliorando certamente la partecipazione della cittadinanza all’evento culturale. Non solo. Nell’attività galleristica Menato è riuscito a mantenere vivo il legame tra il territorio e quegli artisti che da esso si erano allontanati per realizzare la propria maturazione artistica e, allo stesso tempo, si è anche prodigato per valorizzare quegli artisti che avevano fatto la scelta contraria di non uscire dalla valle, dalla provincia ma di sfidare da qui il mondo dell’arte.
Un’attività, quindi, per il territorio e per l’arte a tutto tondo. Un esercizio di critica d’arte che non ha mai subito alcun condizionamento, né politico né poetico. Ha diretto gallerie civiche sotto amministrazioni di tutti gli orientamenti politici, in passato democristiane, di sinistra e di centrosinistra, ieri forziste e di centro destra, oggi leghiste, rimanendo se stesso; ha proposto artisti di tutte le molteplici correnti del ‘900, senza diventare il cantore di nessuno. In ogni modo ha sempre e solo previlegiato l’arte e il territorio.
Per questo quelle pagine della “Storia di Vicenza”, da cui siamo partiti, sono tra le sue, quelle più rappresentative del suo far critica. In esse c’è tutto Menato. La sua idea di arte, il suo modo di leggerla e di scriverne.
Se prendiamo una qualsiasi di quelle analisi, notiamo che in principio vi è sempre la storia. Egli parte sempre da lì, dal “terroir culturale”, per usare una definizione di Emilio Cecchi. Ovvero dal contesto concreto in cui l’artista si è formato: famiglia, amicizie, società, incontri, studi, viaggi, maestri. Ma lo fa, evitando accuratamente di cadere nel biografismo e, soprattutto, in quei rinvii psicologici sempre latenti in ogni accenno alla vita privata di un artista. Sono i fatti che lo interessano, avvalorati dai documenti, secondo quella “religione del documento” che, per Garboli, in Italia origina dal Carducci.
Quindi si passa all’opera. Alle sue ragioni ideali, l’ispirazione, e formali, la precisione tecnica, per codificarne lo stile, individuando i soggetti ricorrenti. Le opere maggiori, poi, vengono elegantemente descritte e messe a confronto con opere di artisti contemporanei rilevandone affinità e divergenze.
Nei suoi saggi Menato evita la critica concettuale, il ragionare sul senso ultimo dell’opera, che lascia libero e, in un certo modo, invisibile o, al più, appena percettibile, come se il senso fosse l’anima dell’opera, la quale ha nel suo non vedersi, la ragione della sua eternità. Evita pure la letteratura, il racconto del mito della creazione, l’aneddoto di vita, la narrazione del fatto artistico.
La critica strutturale con tutta la sua teoria di linee, segni, gesti, materia, colori, così tanto praticata negli ultimi decenni del ‘900, non gli appartiene. E lo stesso vale per la filologia con i suoi tecnicismi, sebbene vi sia ricorso talvolta per esprimere il proprio giudizio sull’autenticità di alcune attribuzioni.
Nella critica di Menato il criterio scientifico è circoscritto alla storia, quella dell’autore o dell’opera o del contesto dell’uno e dell’altra. Tutto il resto sono sue sensazioni. Emozioni che originano da una profonda conoscenza diretta della materia, che significa senza mediazioni libresche ma da una frequentazione assidua di mostre e musei e artisti, e da “l’occhio assoluto” (Chatwin) di chi possiede il dono di saper vedere, di saper riconoscere la bellezza. Un occhio, quello di Menato, che ammira l’opera preferibilmente dal punto di vista dell’osservatore che da quello del produttore. Menato sa guardare più dalla parte di colui che gode l’opera, di colui che la crea. E in questo senso l’opera è percepita come la vita stessa, una fonte continua d’impressioni. È forse qui la ragione ultima del perché, da cinquant’anni e ininterrottamente, egli ha avuto un’attenzione davvero speciale da parte degli appassionati d’arte che lo hanno seguito nelle sue mostre ma anche in tanti viaggi culturali per visitare i principali musei d’Italia e d’Europa.
Di tutto ciò si trova coerente corrispondenza nella sua scrittura, che è elegante, signorile, cosmopolita alla Berenson, di quelle che, se tradotte in tutte le lingue del mondo, non perdono raffinatezza e cura. Più affine al classicismo de “La Ronda”, che in Vicenza aveva in Renato Cevese il più aureolato campione, che all’impressionismo vociano dello “scriver pittore” (Soffici) di un Roberto Longhi. Una prosa limpida che non aspira a rivaleggiare in bravura con gli artisti di cui illustra le opere, ma si pone come un alto servizio alla loro conoscenza. L’ekphrasis, la descrizione elegante, è la sua cifra naturale. Per questo, coerentemente appunto, non vi troviamo il guizzo, la frase a effetto, la battuta sagace, l’invenzione linguistica. Non si conoscono definizioni di correnti artistiche, formule critiche, buone una volta per sempre, attribuibili a Menato. E non perché queste non appartengano all’intelligenza del prosatore, ma perché non rientrano nella sua educazione di scrittore, che evita i cliché e ha un sacro rispetto per la pagina scritta. Questi accenti, invece, li ritroviamo nella sua oralità. Qui, sì, la frase a effetto, il motto arguto, la provocazione o la battuta polemica, trovano spazio. Menato scrive per la storia da storico; Menato parla al pubblico presente alle sue mostre da critico e, vorrei aggiungere, con un certo talento per lo stare in scena. Gianfranco Contini scrisse che Roberto Longhi confidò agli amici il proprio “rimpianto di non esser stato attore”. Mi piace pensare che anche Menato abbia una spiccata vocazione “teatrale”, meglio “operistica”, da tenore belliniano, essendo egli un melomane con una lunga e assidua frequentazione dei teatri, che l’ha portato a maturare una competenza profonda, da addetto ai lavori, dell’opera lirica.
Ma c’è un altro aspetto importante da cogliere oltre alla scrittura e all’oralità. Sono gli allestimenti delle mostre, che egli segue personalmente, talvolta, ma di rado e tantomeno necessariamente, condividendo con l’autore la disposizione delle opere. È evidente che egli ritiene quest’operazione un modo per esprimere il proprio giudizio sulle opere esposte. Con lo studio e la scrittura, con la presentazione e il contatto con il pubblico, l’allestimento della mostra è il terzo atto per far apprezzare l’arte, per far conoscere un autore, per far amare la sua opera.
Così, in anni come questi, di grande trasformazione o confusione del mondo dell’arte, in cui le fondazioni hanno preso il posto dei musei, le fiere campionarie delle gallerie d’arte, il curatore del critico, il depliant del catalogo e del libro; in cui è il pubblico e non più gli artisti a imporre il gusto, mettendo sottosopra millenni di storia dell’estetica, Menato continua il suo magistero, offrendo scrittura, oralità e allestimento come i tre momenti di un unico atto d’amore per l’arte e per il territorio.
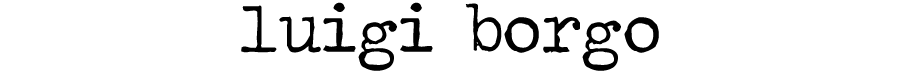




Leave a Reply