La critica d’arte si è fermata a Yalta
Pubblicato su Marana York, maggio 2018Mi pare, e sia detto con kantiana Humanität per esprimere fin d’ora la massima libertà di dissentire dalla mia opinione, che il mondo binario e frontista di Yalta viva ancora in quella che per vocazione avrebbe dovuto essere la frontiera del pensiero più avanzato, libero e aperto, ovvero la critica d’arte. Italiana, ovviamente. La quale, settanta anni dopo Yalta, si divide ancora tra Astrattismo e Figurativismo, prediligendo nettamente il primo al secondo, nonostante la gloriosa stagione dell’Astrattismo storico potesse dirsi conclusa fin dagli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso. Certo, nessuno, nemmeno in provincia, nomina più queste definizioni, “astratto”, “figurativo”, che equivalgono alle obsolete espressioni “cortina di ferro” o “guerra fredda”, ma in sostanza i principi logici-argomentativi e stilistici dell’analisi critica attuale sono sempre bloccati lì, nell’antica dialettica astratto/figurativo e in tutto quel che ne consegue: è astratto ciò che è moderno e nuovo; è figurativo il già visto e il tradizionale. Da qui origina una serie, pressoché infinita, di dicotomiche categorie: surrealismo/realtà, liberismo/socialismo, infinito/finito, trascendenza/immanenza, segno/senso, materia/opera, concettualismo/oggettivismo, avanguardia/memorialismo, forma/contenuto, significante/significato, alto/basso, fino ad arte/artigianato, che sono i tibicines, cioè i puntelli concettuali, di ogni discorso sull’arte contemporanea.
Ma Yalta non è soltanto la divisione del mondo in due blocchi opposti e nemici, Yalta è fondamentalmente una scelta di campo sui principi di vero, di bene, di bello e i loro contrari. Di qua noi, coloro che sanno capire l’arte contemporanea; di là gli altri, coloro che sbagliano. E la scelta fu, come abbiamo già detto, l’Astrattismo, la sua idea d’arte e i suoi principi artistici: segno, gesto, materia, geometrismo, colore, antinaturalismo, avanguardia, sperimentalismo, relativismo, concettualismo, provocazione, trasgressione… Fu, settant’anni fa, una scelta di campo assolutamente centrata per rinnovare una società che usciva dalle guerre mondiali, dai totalitarismi e dalle loro oppressioni, chiusure, atrocità. Dal pensiero della “società aperta” si arrivò “all’opera aperta”, dal relativismo al “pensiero debole” come antidoto alle verità dogmatiche e assolutistiche del passato.
Oggi mi pare, sempre kantianamente sussurrato, che gli artisti abbiano smesso di fare quadri tutti blu o di pugnalare le tele o di esibire il proprio orinatoio o di inscatolare le proprie feci. Sono passati così tanti anni da quando lo facevano, che “il nuovo” è diventato oggettivamente “vecchio”. Oggi, piuttosto, molti artisti sono tornati alla pittura, alla figura umana, alla natura, ai paesaggi, alla scultura realista. E questo è accaduto senza negare la grande lezione della stagione astratta dell’arte. Anzi, moltissime opere degli anni Duemila presentano una convivenza armoniosa dei due generi, che li nega entrambi. Accade allora che la critica d’arte, ultima custode degli equilibri di Yalta, chiamata a registrare queste nuove proposte, incorra in ragionamenti che palesemente si avvitano su se stessi, in giudizi di valore che sono così vaghi da poter essere riferiti a qualsiasi artista da Fidia in poi.
Ecco, brevemente, tre casi d’imbarazzo. Il primo: la questione del significato. Nel codice di Yalta dare un senso a un’opera significa ucciderla. Perché l’opera vive solo e soltanto nelle infinite interpretazioni che essa sa generare. Avvezza così, la critica, a scrivere solo sull’aspetto strutturale dell’opera, ovvero sul segno nel suo divenire forma con teorie di linee che diventano angoli e poi curve e infine cerchi; macchie di colori tonali che diventano timbriche strisce striate, in cui il senso del tutto è quello di essere meravigliosamente se stessi tra i simili e i dissimili della grande storia dell’arte contemporanea, alla presenza di un corpo, all’apparire di un fiore, di un ortaggio, di un paesaggio, la critica non sa più che dire, non sa più che fare, se non affidarsi al celebre teorema di Rorty, secondo il quale, girando e rigirando le parole, si arriva a dar loro una forma, che servirà a completare la pagina e mezza richiesta. Ma l’esito è alquanto tormentato e infelice.
Il secondo: la questione dell’arte come l’assolutamente nuovo. È ancora una prerogativa dell’arte porsi in termini di novità? Per i critici di Yalta la risposta è sì. Per tutti gli altri, artisti compresi, è no. Da tempo si è capito che nulla è e può esser nuovo, ma tutto è solo e soltanto un continuo, ossessivo, opprimente, quasi sempre disonesto, aggiornamento dell’identico. Oggi dai cloud piovono, sincroni in ogni luogo di questo come dell’altro emisfero, nelle fabbriche come nelle case, nei computer come nei telefonini aggiornamenti obbligatori del nostro sempre più tecnologico modo di lavorare, di studiare, di vivere. Chi non è aggiornato, è il nuovo escluso. L’umanità intera è avvezza al nuovo continuo. E ne ha in uggia come la più banale e fastidiosa delle dipendenze. Gli artisti, mi pare, condividano il pensiero che il nuovo per il nuovo oggi non ha più quel senso che aveva un tempo.
Terzo: la questione dell’arte come trasgressione, disubbidienza, ribellione alle regole sociali imposte. Ovvero arte come dissacrazione. È notizia di questi giorni che le autorità del Vaticano hanno concesso alle suore di clausura la possibilità di tenere comunicazioni e amicizie extra conventuali attraverso i social. Vorrei allora porre a un critico questa domanda: dopo che anche le suore di clausura non sono più così segregate come la loro libera scelta imporrebbe, chi oggi dovrebbe ancora essere emancipato dallo shock trasgressivo e catartico dell’arte? Non si accettano risposte secondo il teorema di Rorty, ovviamente.
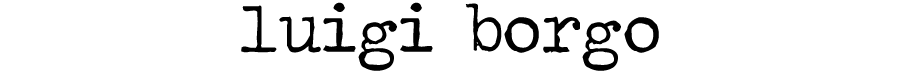




Leave a Reply