Le cinque Carèghe di Gibo
Pubblicato sul catalogo Grifo, novembre 2017Più di altre, la trentennale ricerca artistica di Gibo si è dipanata essenzialmente per grandi cicli tematici, avendo Gibo trovato fin da subito la sua speciale cifra stilistica nel canone dell’iperrealismo e ad esso avendovi dato un proprio originale apporto: quel contenuto di “purezza”, per cui ogni opera non è copia, ma invenzione di un oggetto solo ascrivibile al reale e non a esso appartenente, e in cui ogni opera ha un solo materiale compositivo, il ferro, che assume di volta in volta sembianze altre da sé. Questa assolutezza formale e questa unicità nella scelta materica per la propria opera fanno sì che la vicenda artistica di Gibo abbia le sue più significative variazioni e tensioni nei temi di volta in volta assunti e, quindi, la sua “narrazione” non possa che avvenire attraverso di essi. È una prospettiva critica, questa, di “minoranza” nella storia dell’arte degli ultimi cent’anni, in cui le dinamiche della forma nella pluralità dei materiali adottati dai vari artisti sono state dominanti.
Inoltre più di ogni altro, il canone artistico dell’iperrealismo ha un fine estetico dichiarato: la più totale somiglianza al reale fino, titanicamente, a sostituirvisi, addirittura a sovrastarlo, per perpetrare l’inganno che ciò che non è, sia. Ne consegue allora che l’opera iperrealista nella sua chiara tensione a essere più reale del reale, abbia – anche in questo caso in una posizione d’eccezione rispetto a qualsiasi altro canone artistico – una manifesta verificabilità dell’esito. Il quale non è discutibile. O ha l’impronta del reale al punto di confonderci oppure è un fallimento. Pertanto l’esattezza, che è il secondo momento dell’arte, il primo è l’ispirazione, è un carattere dato della poetica iperrealista, dove la materia, nel caso di Gibo il “dinastico” ferro, non deve essere più riconoscibile come tale.
Potrebbe aprirsi qui una nuova pagina su questo ferro atavico – sono più di cent’anni e sono quattro generazioni che i Lora-Perlotto, di cui Gibo è un diretto discendente, sono artisti del ferro, impiegato ogni volta con canoni formali diversi. Una pagina di critica psicologica. Nella vocazione iperrealista di Gibo, che lo porta, per statuto interno, a usare il ferro affinché non sia più riconoscibile come ferro, potrebbe celarsi il desiderio, se non proprio di “uccidere” la sua storia, di realizzarne uno scarto, quasi una fuga libertaria… in modo che il prossimo artista dei Perlotto possa usare, senza scandalo familiare, qualsiasi materiale… Ma questa è solo una suggestione.
Nella compiutezza formale e nella monacale scelta materica un’interpretazione psicologica delle scelte gibiane centrate sull’eterna, e ormai banale, ribellione dal sangue avito, dice poco, così come una lettura formale-strutturalistica delle sue creazioni è scarsamente applicabile: l’impiego di 120 metri di tondino di ferro da 5, 6, talvolta anche da 8 mm, intrecciato per innumerevoli volte da passaggi a mano per realizzare la seduta della sedia è una curiosità, più che un significato. Vero è, invece, che in questa metamorfosi del ferro in legno, paglia (le carèghe)… in carta, budello, velluto (i libri)… in uova, salame, tabàro, sgàlmare (la memoria contadina)… in pomodori, verze, asparagi, uva (l’orto)… pennelli, tubetti, colore (i cavalletti d’arte)… in qualsiasi materia, in tutta la materia… Gibo vive e fa vivere, a chi ne ammira l’opera, l’essenza dell’arte, la sua potenza e magia trasformista, per cui da un segno nasce un senso, da una figura un’emozione nuova per – il verbo che segue è di David Maria Turoldo – il nostro “giovare”, ovvero per la nostra gioia nel giovamento.
E allora perché Gibo addotta il canone iperrealista, primo e unico nell’affollato panorama mondiale degli scultori del ferro? Tutte le correnti artistiche sono, a mio avviso, sempre seconde a un evento storico “epocale”, che ha fatto loro da “incubatrice” e di cui esse poi sono state lo sviluppo estetico-formale-intellettuale. Mi spiego: prima viene l’età delle grandi Signorie con i loro commerci e la loro nuova forza economica e poi la grande arte del Rinascimento, che di quel mondo si è fatta canone estetico e contenuto di lode e di critica; prima accade la Contro Riforma poi l’Arte Barocca; prima la Rivoluzione Cosmologica poi l’Illuminismo; prima la Rivoluzione Industriale poi il Romanticismo, prima le Guerre mondiali poi l’Esistenzialismo… La scelta iperrealista di Gibo risale agli anni Ottanta, agli albori di quello che è stato lo sconvolgimento “forte” della nostra Età della Tecnica con l’inizio di quella che potremmo chiamare la Web Side Story. Il computer e le sue applicazioni hanno rimesso in gioco con nuova potenza la corrente iperrealista, nata negli anni Settanta con il diffondersi della fotografia, l’altra macchina. Gibo è il primo e attualmente ancora il solo scultore del ferro a produrre arte iperrealista, riconoscendovi, nella sfida ferro versus pixel nella rappresentazione esatta del reale, il linguaggio più penetrante e dirompente per esprimere il proprio libero, critico, artistico, salvifico, ma a questo punto potremmo anche dire “giovevole e gioviale”, discorso sul contemporaneo.
Sono quindi i temi a formare i capitoli della storia di Gibo. Storia di significati e non di significanti. E i temi sono il libro, l’orto, la memoria contadina, le metal-morfosi, le nature morte, i cavalletti di pittura. Ogni tema è un momento del suo speciale sentire di uomo e di artista nell’instabile età dei cloud. E quello delle sedie, il più contenuto per numero di opere, soltanto 5, è centrale della sua ricerca, come lo stesso Gibo, sempre vigile sulla sue intenzionalità comunicative, ci svela in un suo scritto.
Prima di lasciare a lui la parola, va fatta una premessa. Dei temi gibiani, i più, tra cui le nostre Carèghe, appartengono al mondo rurale-naturale di quella provincia veneta, di cui Gibo è originario. Franco Fortini, parlando di un altro artista veneto fortemente ispirato dal paesaggio della sua terra, Zanzotto, ha scritto, che questa dominanza tematica di tipo naturalistico si spiega dal fatto che in provincia la natura “si libera” più facilmente che in città, perché lì, in specie nella terra veneta, è la società a essere “immobilizzata”. La natura veneta, fa notare Fortini da una prospettiva esogena, è più vitale della società veneta. Ferdinando Bandini, da una prospettiva opposta, endogena, gli ha risposto che è proprio nella provincia veneta, in quello che poi si sarebbe chiamato Nordest, si sono vissute in modo “molto più violento” quelle trasformazioni sociali e culturali, iniziate già negli anni Cinquanta in Italia, che sono state la causa del nostro presente attuale. Questi radicali cambiamenti si sono avvertiti sulla pelle dei veneti più di quanto “non potesse percepire un pigro sguardo ‘metropolitano’, reso pigro perché quanto di nuovo appariva gli poteva sembrare erroneamente simile a fenomeni pregressi e consolidati”. La modernità devastante di fine XX secolo, insomma, è stata più sconvolgente in provincia che nelle grandi città. Il secolo che era iniziato mettendo in crisi tutto, con dichiarazioni di morte di ogni valore, morte di Dio, morte della cultura, dell’arte, della poesia, della famiglia, si concludeva con la morte, ma in questo caso non solo dichiarata, ma di fatto, dei valori della terra e delle sue tradizioni. Crisi umana e crisi sociale.
Così tutto un mondo rurale veniva violentemente spazzato via. Abbattute le fattorie e divelte le colture per erigere scriteriatamente condomini e capannoni; bruciati i vecchi mobili e le vecchie sedie di paglia per far posto, prima, a quelli in formica e a quelli plastica, poi, alle nuove sedie in simil-paglia prodotte in Cina. “È stata la nostra lunga notte dei Cristalli”, racconta Gibo, “là si bruciarono i libri e la libertà di pensiero, qui si bruciavano le carèghe e le nostre origini”.
Con la differenza, però, che i libri erano bruciati dai nazisti, storicamente il male assoluto dell’Umanità, le carèghe dal medesimo sangue di chi le aveva costruite e sempre fatte aggiustare. Di Zanzotto, tratto da “Idioma”:
Conzacareghe, caregheta
Riva riva i caregheta
Che i é cofà ‘na società segreta
I à ‘n dèrego che sol che lori i sa
E ‘na sior’Ana che sol che lori i sa:
eco ‘l primo che ‘l passa,
l’impaja la carega e inte la paja ‘l ghe assa
una renga che ‘l gat sgrifarà via,
cussì quel che vien dopo, bon colega,
catarà ‘na carega
anca lu da inpajar, e così sia.
Impagliatori di seggiole, seggiolai
Arrivano arrivano i seggiolai
che formano tra loro quasi una società segreta,
usano un gergo che solo loro conoscono
e hanno un vuoto in pancia che loro soli sanno:
ecco il primo che passa,
impaglia la sedia e tra la paglia lascia
un’aringa che il gatto strapperà via
così chi verrà dopo, buon collega,
troverà una sedia
anche lui da impagliare, e così sia.
Era un mondo rurale in cui la solidarietà lavorativa esisteva e non esisteva la concorrenza. Un seggiolaio aveva sempre una seduta in paglia da poter rifare. Glielo garantiva chi era venuto a svolgere il lavoro prima di lui, lasciando un po’ di unto d’aringa tra i nuovi steli, al resto poi ci pensava il gatto.
La prima “carèga” di Gibo è del 1998, in merito alla quale scrive di esser stato ispirato dal ricordo del nonno Francesco, che aveva una “sua” carèga, come ognuno in casa aveva la propria, di cui era anche responsabile. La “carèga” era il suo “trono” di capofamiglia, racconta Gibo, e del suo corpo la sedia aveva preso lo stampo: la seduta era sfondata dal peso e dai decenni di utilizzo. “Quando furtivamente mi ci sedevo da piccolo, avevo la percezione di tutta l’imponenza del suo corpo adulto rispetto al mio di bambino”. Fa notare Angelo Falmi, artista oggi impegnato nella realizzazione di una serie di 99 tele sul tema della sedia, che essa è l’oggetto più antropomorfico di ogni altro. Ogni sua parte rinvia nella forma e nel lessico al corpo umano: schienale, braccioli, seduta, gambe, piedi. Quasi la sedia fosse l’ombra o l’angelo custode dell’uomo, pronto sempre a soccorrerlo e a dar a lui un sostegno. La sedia di nonno Francesco scrive Gibo: “non aveva mai un posto definito, girava per la casa e per la corte seguendo il sole: al mattino era affianco all’uscio con una scodella e un cucchiaio, a mezzogiorno stava a capotavola per il pranzo, nelle ore calde del meriggio la si vedeva sotto la pergola e al tramonto vicino al camino scoppiettante. Spiriti fluttuanti la spostavano di continuo, ombre che non riuscivo ad acchiappare”.
Nel 2014, sedici anni dopo quella prima prova, Gibo ne realizzerà un’altra, intitolata “Loro dove sono?”, nel cui schienale è appesa una fionda, il gioco infantile preferito da Gibo. Nella seduta sfondata torna il nonno e, attraverso la fionda, Gibo bambino. Potrebbe sembrare la più pascoliana delle sue opere: una “regressione all’infanzia”, dove resuscitare il nonno e rasserenarsi sotto la sua protezione, rivivendo la felicità delle ore spensierate trascorse a giocare con la fionda nei campi e nella corte di casa, fuori dalla storia e dai suoi orrori, lontano dalla decadenza sociale e i suoi obbrobri. Ma in Gibo non c’è, come in Pascoli, una fuga dal mondo, non c’è il desiderio di rinchiudersi nel proprio “nido” familiare, nella sicurezza del sangue come ultima salvezza, perché in Gibo non c’è quella paura della morte, che era al centro della poesia del Pascoli. Il suo simbolismo non è, quindi, di tipo psicologico, ma storico-sociologico. Anche nell’altro suo grande tema, quello dell’Orto, non vi è un ricorre alla natura per fuggire dal presente, ma la natura, gli ortaggi, come appunto le carèghe, le opere della memoria contadina, fino ai libri, sono i temi-oggetti con cui contrastare la deriva sociale e umana del suo tempo.
Prova ne è la carèga, realizzata (2011) tra le due sopra menzionate, dedicata alla figura di Padre David Maria Turodo e intitolata “Mistica solitudine”. Gibo ha conosciuto Turoldo. Si erano incontrati verso la fine degli anni Settanta. Gibo conserva una pagina mirabile del suo diario su quel giorno. Era una mattina di primavera e lui frequentava, senza voglia, la scuola per geometri a Vicenza. A volte gli era proprio difficile entrare in classe e così “marinava”. Lo faceva da solo, senza compagni. In quelle ore di non istruzione, doveva pensare, per questo preferiva andare da solo in giro per la città. Quella mattina di primavera sale a Monte Berico. È il posto ideale, quando c’è il sole e la primavera è tutto uno sbocciare. Ma Gibo, quella mattina, entra in basilica. C’è un po’ di gente ma poca e, rispetto alla luce abbagliante del belvedere, dentro è quasi buio pesto. Passando davanti a un banco, sente una voce che gli dice: “tu, dove vai?” È una voce cavernosa, profonda, antica, che esce da un volto di frate d’altri tempi, con un naso grande, piovorno, e con i capelli filiformi che scendono lunghi ai lati, ad allungare quel volto già di per sé lungo. È Padre David Maria Turoldo. Gibo prima tenta una scusa: “gli dissi che c’era sciopero”, ma subito si sente rispondere: “bugiardo”. Allora confessa: “ho marinato la scuola”. Turoldo sa che non si marina la scuola per entrare in una basilica. Parlano un po’, quindi Turoldo, congedandolo, gli dice: “tra dieci giorni ci rivediamo qui, però dopo la scuola, e mi dirai dove ti ha portato il tuo pensare”.
Dopo il nonno Francesco, è la seconda persona cui Gibo dedica una carèga. Evidentemente ha sentito il dovere di fissare l’impronta anche di quella vita speciale. Turoldo era friulano e alla terra e all’umiltà delle sue origini è sempre stato fedele. Le carèghe de paja appartengono anche alla sua storia. Vi è una poesia molto bella di Turoldo, cara a Gibo, che di fronte ai grandi misteri della fede, che sono della stessa materia con cui sono fatti gli irrisolvibili misteri dell’arte, dice:
Signore,
ma da me avrai appena
rudi versi: stanze di versi degni della mia
miseria d’origine.
Ad altri […] celebrare il favoloso corteo:
[…] Ma la madre mia contadina
del mio Friuli, la più povera
del paese usava dirmi: “Figlio
sono cose troppo grandi per noi!”
Questa altissima umiltà è anche nelle carèghe di Gibo, che esprimono la voce della terra natale, del Veneto rurale, ricco di fede e di poesia. Non è allora una fuga pascoliana nel “nido”, quella che le Carèghe di Gibo evocano, ma è un andare verso quella “verità” che il mondo contadino, con i suoi dolori e sofferenze, con la sua umiltà e sincerità, con il suo saper lavorare e il suo sacro rispetto per il lavoro altrui, sapeva esprimere.
Turoldo è stato un poeta che ha trascinato in giudizio la storia e il presente. Della sua poesia si è detto che contenesse un tono “biblico-profetico”. Se osserviamo l’ultima carèga di Gibo, quella realizzata nel 2016 e intitolata con l’espressione biblica “Sic Turbo” con una trottola posta sulla seduta quasi a gridare con Turoldo: “più non distruggere il mio tempo, occidente”, ovvero ferma la trottola della follia dilagante, oppure se riflettiamo sul messaggio dichiarato fin dal titolo della collana dei libri “I Dodici Apostoli” del 2017, titolo “biblico-profetico-evangelico”, cogliamo la profonda affinità dell’opera di Gibo con il pensiero turoldiano, da cui si definisce il senso di quel ricorrere al tema contadino, etico e valoriale, non pascoliano ma, si potrebbe dire, di scuola veneta: oltre a Turoldo, Zanzotto, Camon, Rigoni Stern e prima di tutti Pasolini poeta di Casarsa.
Ma la carèga dedicata a Turoldo tocca anche un aspetto personale del vecchio prete-poeta-profeta, la sua solitudine, la sua consapevolezza di essere stato dimenticato dagli uomini, quegli “ultimi”, per i quali aveva avuto un impegno quotidiano per tutta la vita. Le sue prediche nel Duomo di Milano, le sue invettive, le sue dichiarazioni, i suoi lamenti, la sua spinta a voler rinnovare anche l’istituzione religiosa, la sua stessa poesia alla fine caddero nel vuoto.
…Poi
il buio assoluto
compatto come pece:
un buio da non sentirsi più
neppure esistenti
—
Poi il silenzio
solo silenzio
assoluto silenzio:
muto
plumbeo
fittissimo
silenzio!
La solitudine irrisolvibile di Turoldo rivive nel “racconto” della carèga di Gibo per diventare la solitudine in cui è sprofondato l’uomo contemporaneo. Le sedie sono vuote. Testimoni di una presenza che fu. Angeli custodi senza più uomo. Nessuno ora viene a occuparle. Cessata è la partecipazione. Tutti viviamo a distanza sulle piattaforme o dentro la net di virtuali dialoghi amicali, in ogni momento interessati alle necessarie informazioni meteorologiche, offerte dalle App dei nostri cellulari. Le sedie sono vuote attorno al tavolo della famiglia, nelle navate delle chiese, nelle sedi di partito, nei salotti degli incontri culturali, nelle sale dei cinematografi, nelle platee dei teatri. Quanta fatica a riempire qualche posto, quando ci si incaponisce a farlo.
Sono 5 le sedie di Gibo… un numero dispari, come se alla sua tavola ci fosse una sedia pronta ad aggiungersi, affianco a quella dedicata a Vivaldi, intitolata “Rosso primavera”, realizzata nel 2015, la più virtuosa di tutte con il suo violino, sublime omaggio alla “veniticità” e al genio della sua gente: è la sedia dell’artista, del poeta, a cui chiedere un segno…
Un verso…
Fessura sull’infinito come
Il costato aperto di Cristo…
Un solo verso può fare
“più grande l’universo”.
(David Maria Turoldo)
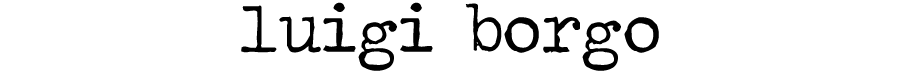




Leave a Reply