Questione di energie
Pubblicato su Sciare – 2007E’ tutta una questione di energie. Lo è la durata della carriera di un campione, la produzione di una grande opera d’arte, il successo di un’attività imprenditoriale. Ho letto un’intervista a Marchionne il grande capo Fiat, dove fa capire che per realizzare il miracolo di risollevare l’industria automobilistica italiana sta dando il massimo di se stesso e a chi lo vorrebbe poi a Trenitalia o all’Alitalia o magari a capo dell’Italia stessa, lui dice che a certi ritmi non si può andare avanti in eterno. Anche i campioni sono esseri in divenire, che partono da zero e arrivano a zero, e il meglio di se stessi, se va bene, lo danno per il 15% della propria vita. Vorrei che questo concetto abbastanza evidente fosse compreso dai professori dei nostri ragazzi quanto dai presidenti e dagli allenatori degli sci club. Può dipendere in parte da loro richiedere quel 15% di fuori giri nel momento sbagliato e grippare tutto. Avrete presente il secchione del liceo che all’università arriva cotto e stracotto. O il ragazzino che tra gli allievi va come una bomba e poi in Comitato s’impianta. E’ sempre la solita questione di energia, che va gestita, soprattutto quando la gara è lunga come la vita. La forza di Tomba, credo, sia stata quella di vincere relativamente poco da bambino. Come Bettini, che dieci anni prima di conquistare il suo secondo mondiale di ciclismo nessuno lo voleva tra i professionisti. Al primo mese di scuola media mio figlio è venuto a casa che doveva studiare il peso atomico, il legame covalente e quello ionico. Come a dire che a 11 anni, per l’allenamento estivo lo avrei dovuto mandare due mesi a Portillo, Cile. Gli ho detto alt: prima di studiare la chimica, prima di fare la sacca per Portillo, senti questa storia. Mario Capecchi è il genio italo americano che quest’anno si è meritato il Nobel per aver “aperto la scatola nera delle cellule staminali”. Roba davvero seria. Eppure a 11 anni faceva ancora la terza elementare in una comunità quacchera, senza nemmeno conoscere la lingua inglese che usavano a scuola. Era nato in Italia, ma aveva subito perso il padre, morto in un duello aereo durante la Seconda guerra mondiale. Gli era rimasta la madre, una tipa alquanto ribelle e bohemien, anche se di buona famiglia americana, che però fu deportata a Dachau. Capecchi aveva tre anni e mezzo quando fu affidato a una famiglia dell’Alto Adige in cambio degli averi della madre. Ma finiti i soldi, a 5 anni lo mettono alla porta. E lui vive “con bande di teppisti e altri orfani” cercando di cavarsela. Fino a nove anni gira a vuoto. Poi, chissà come, dall’Alto Adige arriva a Reggio Emilia, dove è ricoverato in ospedale per malnutrizione. “Dormivamo nudi sul materasso” nutrendosi solo con croste di pane e acqua. Finalmente un giorno la madre lo ritrova e lo porta in America. Ma lei, già strana di suo prima, “non ha mai superato il trauma di Dachau e ha vissuto in un mondo di fantasia fino alla morte”. Come a dire che la vita al piccolo Capecchi anche in America non era cambiata di molto. Però, sessant’anni dopo, lui vince il Nobel chiedendosi se l’avesse vinto “nonostante o grazie alle esperienza della sua infanzia”. Si può preferire il “nonostante” e credere al fatalismo, ma è decisamente più educativo il “grazie” e in quella terribile infanzia intravedere il buonsenso di chi non ha studiato il peso atomico con i genitori senza capirne un cavolo e non è andato a Portillo per essere sicuro di qualificarsi per le regionali. I veri studi, come il vero sci, inizia dopo gli 11 anni, Capecchi docet.
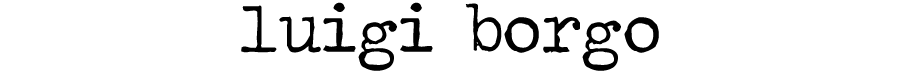




Leave a Reply